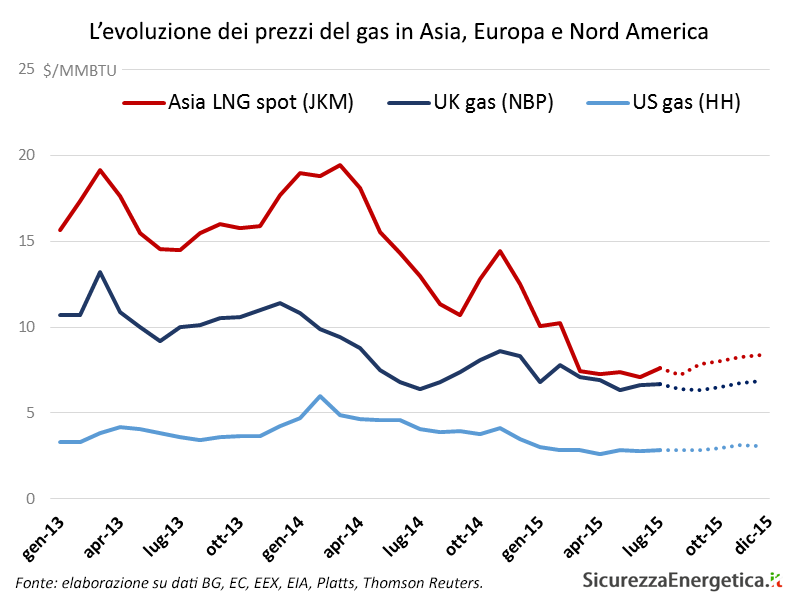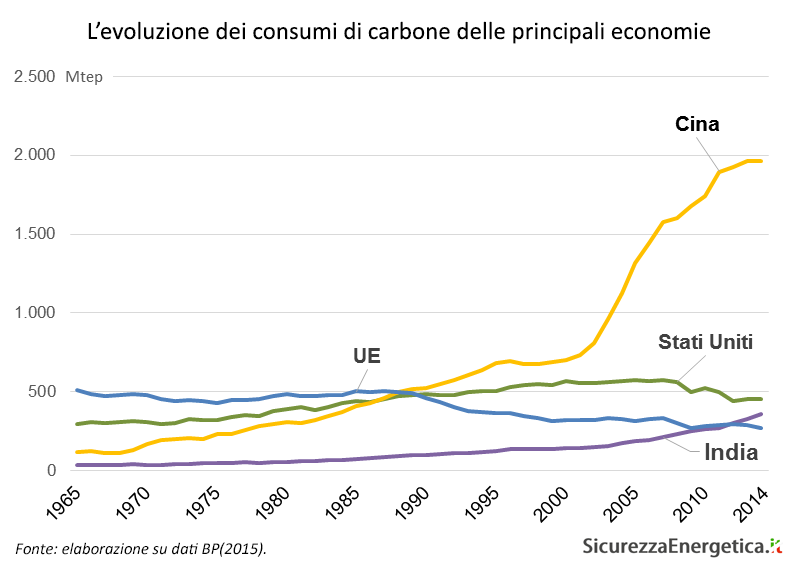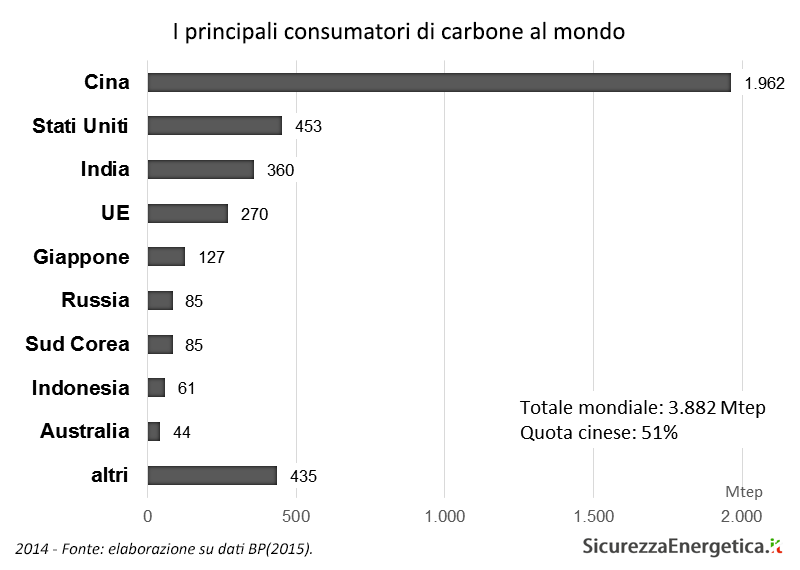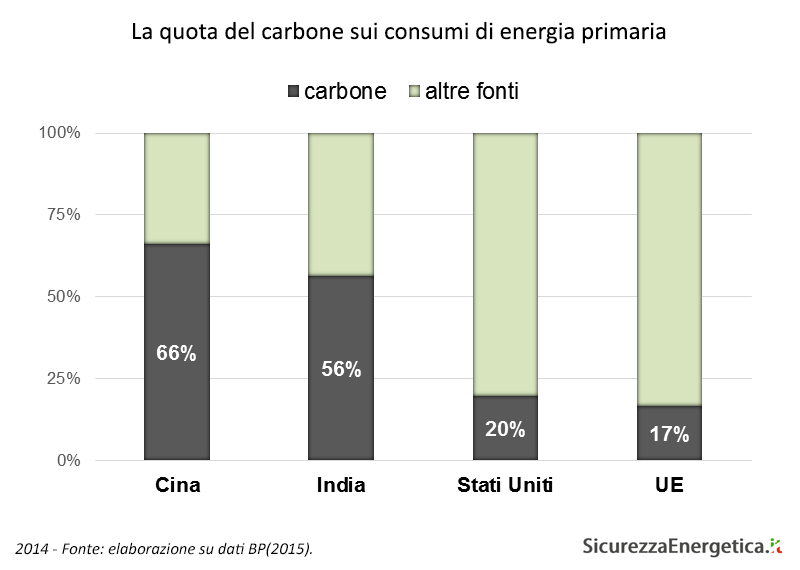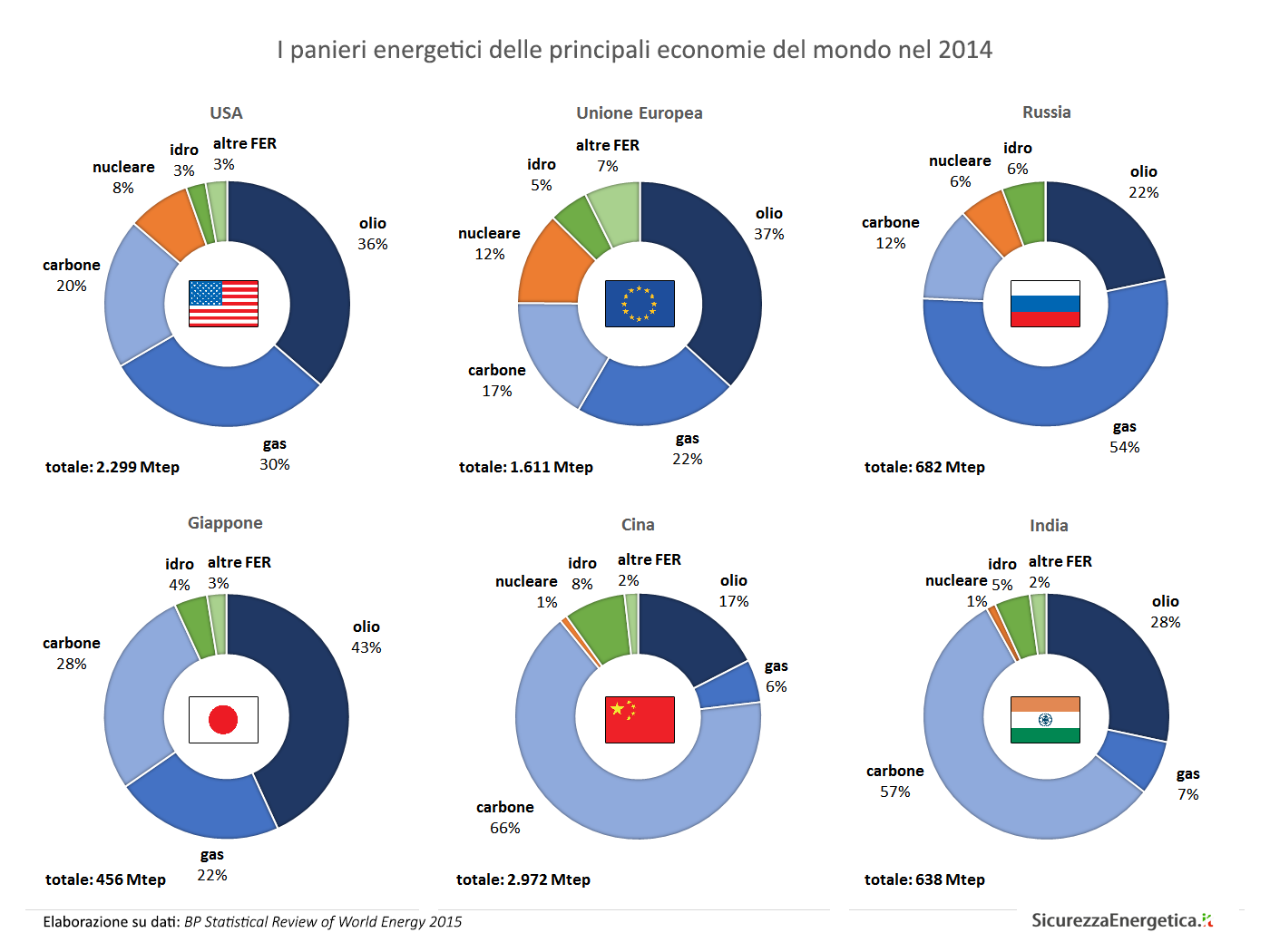David Einhorn, noto per aver messo in dubbio la stabilità finanziaria di Lehman Brothers nel 2007, ha fatto qualche giorno fa un’interessante presentazione nella quale attacca i fondamenti delle principali società che sfruttano di shale oil statunitense (e non quello che si occupano principalmente di shale gas, che invece definisce competitive).
David Einhorn, noto per aver messo in dubbio la stabilità finanziaria di Lehman Brothers nel 2007, ha fatto qualche giorno fa un’interessante presentazione nella quale attacca i fondamenti delle principali società che sfruttano di shale oil statunitense (e non quello che si occupano principalmente di shale gas, che invece definisce competitive).
Se avesse ragione, si tratterebbe di un fatto epocale, giacché l’aumento della produzione statunitense è valso da solo alcuni milioni di barili di produzione giornaliera, contribuendo in modo determinante all’eccesso di offerta che ha fatto crollare le quotazioni del greggio l’anno scorso. Se i fondamenti economici della produzione di shale oil fossero davvero meno solidi di quel che comunemente creduto, ci sarebbero forti ripercussioni sia sui mercati finanziari (chi ha prestato i soldi alle società) sia quelli petroliferi (dove l’eccesso di offerta potrebbe venir meno).
Come mette in evidenza FT, Einhorn sottolinea soprattutto tre aspetti. Il primo riguarda il modo in cui le società riportano i ricavi, in particolare non tenendo adeguatamente conto del fatto che le spese in conto capitale non creano un asset, ma anzi lo riducono (estraendo l’olio dalle concessioni).
In secondo luogo, Einhorn si focalizza sui flussi di cassa come indicatore della salute delle imprese. Dal 2006, la differenza cumulata tra quanto speso dai principali produttori di shale oil aper acquisire diritti di trivellazione e produrre è stata inferiore a quanto speso di circa 80 miliardi di dollari. In pratica, i produttori di shale oil hanno fin qui bruciato liquidità, restando a galla solo grazie a ulteriori afflussi di capitali.
In terzo luogo, Einhorn sostiene che gli investitori convinti che il prezzo del greggio sia destinato a salire farebbero meglio a investire direttamente sui prodotti finanziari collegati al petrolio piuttosto che sulle società di produzione da shale oil, che resterebbero non competitive.
Come nota FT, la situazione merita attenzione, ma forse non è grave come Einhorn sostiene. Quanto ai flussi di cassa, i diritti acquisiti e l’expertise accumulata consentono ai produttori di continuare a produrre anche in futuro e a costi decrescenti.
Proprio nei costi si trova in fondo la risposta ai dubbi (legittimi) di Einhorn sulla sostenibilità dell’industria statunitense dello shale oil statunitense. In risposta al crollo dei prezzi del greggio, gli operatori hanno tagliato drammaticamente i costi e aumentato l’efficienza delle proprie operazioni. Chi riuscirà a farlo meglio resterà sul mercato, gli altri saranno travolti progressivamente, in base a quanto a lungo le quotazioni del greggio resteranno sotto i costi di produzione.
Ci saranno vittime, insomma, ma molti produttori si sono dimostrati parsimoniosi, innovativi e resilienti: probabilmente lo shale oil statunitense è destinato a restare un elemento dei mercati petroliferi mondiali anche in futuro.